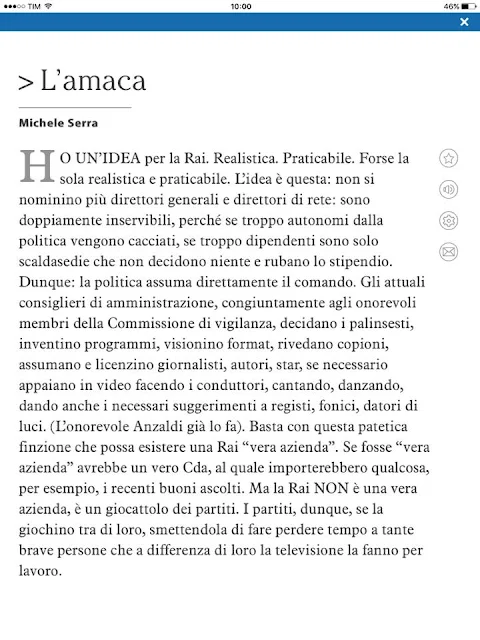Un luogo ideale per trasmettere i miei pensieri a chi abbia voglia e pazienza di leggerli. Senza altro scopo che il portare alla luce i sentimenti che mi differenziano dai bovini, anche se alcune volte scrivo come loro, grammaticalmente parlando! Grazie!
mercoledì 24 maggio 2017
Punti di vista
Stringe semplicemente la mano alla figlia di uno che parrebbe aver sfanculato i risparmi di migliaia di persone per bene. Io non gliela avrei manco toccata! E il sedicente giornalista Lavia pensi piuttosto a bere tanta acqua che con l'uso smodato della lingua pro Bomba rischia il mutismo!

Articolo
mercoledì 24/05/2017
Stragi e autostragi
di Marco Travaglio
Cosa direste se, dopo la strage di Manchester, qualche pezzo grosso dello Stato, della politica, delle forze dell’ordine e dei servizi segreti britannici si mettesse al lavoro non per scoprire e punire tutti gli esecutori, i complici e i mandanti della mattanza, ma per coprirli facendo sparire le loro carte e quelle degli inquirenti, lasciandoli fuggire pur avendoli sottomano, depistando le indagini con falsi colpevoli, lasciando incustoditi i loro covi a beneficio dei compari, intimidendo o facendo ammazzare i testimoni e magari aprendo una trattativa Stato-Isis per addolcire il trattamento carcerario ai detenuti, smantellare le più importanti leggi antiterrorismo del Paese, screditare, isolare e punire i magistrati che indagano sull’immondo mercimonio? No, perché è esattamente quello che è accaduto in Italia durante e dopo le “auto-stragi” del 1992 a Palermo e del 1993 a Firenze, Milano e Roma. Eppure i rappresentanti di quello stesso Stato che 25 anni fa negoziò con Cosa Nostra sulla pelle di decine di vittime innocenti continuano a commemorarle con orge di retorica e lacrime di coccodrillo. Il massimo dell’autocritica è la solita, trita polemica sulla mancata nomina di Giovanni Falcone a capo dell’Ufficio istruzione o della Procura nazionale antimafia, o sulla diffidenza che accompagnò la sua opinabilissima scelta di collaborare col governo Andreotti. Sui mandanti o i complici istituzionali e dunque occulti delle stragi, sugli artefici della trattativa Stato-mafia che le moltiplicò e sui depistaggi per coprire le tracce, silenzio di tomba.
Ieri, in un’intervista al Fatto, il Pg di Palermo Roberto Scarpinato ha messo in fila una serie di fatti documentati e inoppugnabili, unendo poi i puntini di un disegno che dà i brividi a chiunque voglia dargli un’occhiata. Non furono uomini dell’Antistato, ma del cosiddetto Stato, ad avvertire i killer mafiosi dei programmi di Falcone nel terribile weekend dell’Addaura. A rovistare nei file del suo computer al ministero della Giustizia subito dopo la sua morte. A firmare i comunicati della “Falange armata” per rivendicare e depistare ogni attentato. A essere informati in tempo reale della strategia stragista pianificata da alcuni superboss in un casolare di Enna sullo scorcio del 1991, senza far nulla per contrastarla, anzi. A spedire i carabinieri del Ros dal mafioso Vito Ciancimino per avviare una trattativa con Riina e poi con Provenzano piegando lo Stato al ricatto mafioso; a mandare al macello Borsellino, nemico irriducibile di ogni patteggiamento, in via D’Amelio meno di due mesi dopo Capaci.
E furono sempre uomini dello Stato, non dell’Antistato, a inviare un emissario per sorvegliare il caricamento del tritolo sull’autobomba (forse gli “infiltrati” che la moglie del pentito Santino Di Matteo, intercettata, pregò il marito di non nominare mai dopo il rapimento del figlio Giuseppe, poi ucciso e sciolto nell’acido). A trafugare l’agenda rossa del giudice dal teatro ancora fumante dell’eccidio; a confezionare subito dopo un falso colpevole, Scarantino, da dare in pasto ai pm per nascondere i veri colpevoli e i loro complici o mandanti esterni. A non perquisire il covo di Riina subito dopo il suo arresto, lasciando che gli indisturbati picciotti di Provenzano lo ripulissero di ogni carta e traccia. A decidere la revoca del 41-bis per 334 mafiosi detenuti un anno dopo la tormentata approvazione del decreto sul carcere duro.
A lasciarsi sfuggire nel ’93 Bagarella, inscenando un gran casino attorno al suo nascondiglio nel Messinese per farlo scappare, e poi Provenzano a Mezzojuso nel ’96. Ad avvertire Cosa Nostra che il boss confidente che aveva localizzato Provenzano, Luigi Ilardo, custode di preziosi segreti sugli apparati deviati dello Stato, stava per collaborare con la giustizia e mettere a verbale le sue accuse, per farlo eliminare appena in tempo. E ancora – aggiungiamo noi – a svuotare il 41-bis, a chiudere le supercarceri di Pianosa e Asinara, a depotenziare la legge sui pentiti, ad abolire addirittura (per un anno) l’ergastolo per gli stragisti, proprio come Riina aveva chiesto nel “papello”, ad avviare campagne politico-mediatiche contro i pm antimafia (da Caselli e il suo pool protagonista dei processi su mafia e politica a Di Matteo e agli altri magistrati impegnati tuttoggi nel processo sulla trattativa) e contro tutti i più efficaci strumenti di lotta alla mafia: i pentiti, i testimoni di giustizia, il reato di concorso esterno in associazione mafiosa (ideato da Borsellino nell’ordinanza del maxiprocesso-ter), la custodia cautelare e le intercettazioni.
Naturalmente l’agghiacciante denuncia di Scarpinato è caduta nel vuoto, essendo il muro di gomma l’arma migliore usata dal potere contro le verità indicibili. Ora, immaginiamo che opinione si farebbe dell’Italia uno straniero che vi sbarcasse per la prima volta e leggesse i quotidiani e ascoltasse i tg e i dibattiti televisivi di questi giorni, tutti dedicati a quei mascalzoni dei pm e all’obbrobrio delle intercettazioni. Penserebbe: che strano, di solito sono i mafiosi, i killer, i rapinatori, gli scafisti, i trafficanti di droga, armi e carne umana che parlano solo di come sfuggire a quei cornuti dei magistrati e di quegli stronzi degli inquirenti, di come levarseli dai piedi e farla franca, prima di aprire bocca, si guardano intorno, evitano i telefonini e parlano sottovoce per scansare le cimici; invece in Italia tutte queste cose le dicono e le fanno i politici, che negli altri Paesi hanno preoccupazioni diverse, anzi opposte. Si domanderebbe il perché di questo bizzarro fenomeno e come potrà mai il nostro Stato combattere lo stragismo jihadista. E si risponderebbe: vuoi vedere che in Italia governa la criminalità organizzata? Risposta esatta.
martedì 23 maggio 2017
Articolo
Un articolo illuminante di Attilio Bolzoni che spiega quanto il giudice Falcone abbia dovuto patire durante il suo lavoro. Il gelo attorno a lui fu molto simile alla solitudine mafiosa, preludio di assassinii.
Il tradimento del Csm e quello sfogo con gli amici “Io, consegnato ai boss”
ATTILIO BOLZONI
FORSE è stata la prima volta che ha avuto davvero paura. Di morire, di fare la fine che poi ha fatto. La sera prima era ancora sicuro di farcela. Aveva contato e ricontato tutti i voti che gli erano stati assicurati, una croce sul foglio bianco accanto a ogni nome e a ogni promessa. La sera dopo, nonostante i suoi nervi di acciaio, non è riuscito a nascondere agli amici un’inquietudine che ora dopo ora è diventata angoscia: «Così mi hanno consegnato a Cosa Nostra».
Lo Stato italiano aveva appena delegittimato l’uomo migliore che aveva contro la mafia siciliana. Con un voto vergognoso il Consiglio Superiore della Magistratura aveva “bocciato” Giovanni Falcone come consigliere istruttore del Tribunale di Palermo, al suo posto aveva preferito un anziano giudice con sedici anni di carriera in più alle spalle che però niente sapeva dei misteri mafiosi e delle complicate indagini che da qualche anno stavano mettendo sottosopra la Sicilia. Il 19 gennaio 1988 il giudice che per primo aveva messo paura ai boss era ormai sicuro che, prima o poi, quei boss l’avrebbero ucciso. Il segnale arrivato dal Csm era preciso: sei solo, ti hanno scaricato pure i tuoi colleghi magistrati. Disse al consigliere Vito D’Ambrosio, che si era schierato con lui: «Lì dentro mi hanno crocifisso, inchiodato come un bersaglio ». Disse alla consigliera Fernanda Contri, una sua amica: «Ora possono eseguire senza problemi la sentenza di morte già decretata da tempo, perché hanno avuto la dimostrazione che non mi vogliono neanche i miei».
A Palazzo dei Marescialli quel giorno 10 votarono per Falcone, 5 si astennero, 14 votarono per Antonino Meli. Gli voltarono le spalle anche metà di quelli della sua corrente, Unità per la Costituzione. Altri lo tradirono all’ultimo momento. Uno in particolare, un magistrato della procura palermitana che, subito dopo la strage del 23 maggio 1992, Paolo Borsellino apostrofò pubblicamente “il giuda”.
Ma la storia di quella votazione infame era cominciata molto tempo prima. E i mandanti erano nascosti in Parlamento e al Palazzo di Giustizia di Palermo. Era appena finito il maxi processo, il primo successo dello Stato italiano contro la criminalità mafiosa da quando lo Stato italiano esisteva. Ma il giudice era “troppo avanti” con le sue investigazioni, si stava avventurando nella terra di nessuno delle contiguità. Un pool antimafia che aveva rivoluzionato i sistemi di indagine, che aveva “centralizzato” tutte le informazioni riservate, che si era trasformato in una cassaforte di segreti. Custodita da Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Giuseppe Di Lello, Leonardo Guarnotta. E dal loro capo Antonino Caponnetto.
Ma Caponnetto, dopo quattro anni e quattro mesi — era sceso a Palermo alla fine del 1983 per sostituire Rocco Chinnici saltato in aria a luglio — stava per andare in pensione. Chi, più di Falcone, per competenza, passione, merito, senso dello Stato, avrebbe potuto sedersi su quella poltrona di consigliere istruttore? I nemici di Falcone calarono l’asso di bastoni con astuzia, quasi alla scadenza dei termini delle domande per diventare consigliere istruttore a Palermo. Con un nome: Antonino Meli. Era un magistrato anziano, presidente della Corte di Assise di Caltanissetta, che aspirava alla presidenza del Tribunale di Palermo. Un incarico prestigioso. Alcuni giudici, però lo convinsero a ritirare la domanda per quella poltrona e ripiegare sulla carica — meno importante — di consigliere istruttore. Contro ogni ambizione e logica, Meli accettò il consiglio dei suoi colleghi. Fu la mossa finale per sbarrare la strada a Giovanni Falcone. Fra Palermo e Roma organizzarono la trappola, fra il palazzo di giustizia siciliano e il Consiglio superiore della Magistratura. Giocando tutto sul fattore “anzianità” si arrivò alla votazione del Plenum che ridusse Falcone a carne da macello. Il relatore Umberto Marconi spiegò così la scelta: «Accentrare tutto in figure emblematiche, pur nobilissime, è di certo fuorviante e pericoloso. Ciò è titolo per alimentare un distorto protagonismo giudiziario, incentivare una non genuina gara per incarichi di ribalta... Si trasmoda nel mito, si postula una infungibilità che non risponde al reale, mortifica l’ordine giudiziario nel suo complesso».
La battaglia del Csm non è stata una bega fra magistrati, una rissa corporativa. Antonino Meli in una settimana disintegrò otto anni di indagini di Falcone seppellendo il pool antimafia. Avocò a sé l’ultima inchiesta sul pentito Antonino Calderone e la sbriciolò in una quindicina di tronconi, spedì brandelli di ordinanze a una dozzina di procure sparse per la Sicilia, con una sola firma riportò la lotta giudiziaria alla mafia all’età della pietra. “Spezzatino antimafia”, lo chiamarono i palermitani. All’inizio di quell’estate Paolo Borsellino, che era procuratore capo a Marsala, non rimase in silenzio. E in una clamorosa intervista a Repubblica e all’Unità, accusò: «A Giovanni Falcone hanno tolto la titolarità di tutte le indagini di mafia, la lotta alla mafia è finita». Era il 19 luglio del 1988. Esattamente quattro anni prima dell’autobomba in via D’Amelio.
In memoria
Ci si vedeva quasi sempre di mattino, anzi, all'alba. Tutte e due infatti amavamo quei momenti in cui il silenzio cominciava a rompersi per il risveglio, sempre più generalizzato, della città. Oltre al consueto saluto, chiacchieravamo del più e del meno, secondo la liturgia mattutina.
Franco era un amante ed un intenditore della natura. Amava andare a scorrazzare nei suoi campi, a Valdipino, adorava il contatto con la terra, mi trasmetteva le architetture progettate nella notte che al pomeriggio avrebbe trasformato, attraverso la sana fatica, in realtà. Lavorava in Comune, e ne andava fiero. Amico di tutti, faceva parte di quella schiera di poche persone che, se interpellate per qualsiasi necessità, si rendono sempre disponibili, aumentando semplicemente le ore del giorno.
Franco Figoli non c'è più, se ne è andato all'improvviso, come era nel suo stile, alla Batman. Lo voglio ricordare così in questa alba triste, nella quale prendo impegno solenne di portare avanti la nostra comune condivisione, apprezzando le prossime che verranno, godendo anche per lui della fragranza pregustante l'arrivo di Messer Infuocato.
Ti sia soave la terra, amico del mattino!
Franco Figoli non c'è più, se ne è andato all'improvviso, come era nel suo stile, alla Batman. Lo voglio ricordare così in questa alba triste, nella quale prendo impegno solenne di portare avanti la nostra comune condivisione, apprezzando le prossime che verranno, godendo anche per lui della fragranza pregustante l'arrivo di Messer Infuocato.
Ti sia soave la terra, amico del mattino!
Iscriviti a:
Commenti (Atom)